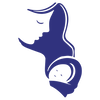La chiesa della SS. Trinità
Da "Segni per la memoria – Epigrafi in Samarate" - Collana: I libri di Samarate, n. 61 - G. Aspesi/F. Piacentini/M. Rossini
Da "il centro" n. 75 - gennaio/aprile 2006 - M. Colombi, G. Chiaravalle
Da "il centro" n. 81 - giugno/settembre 2008 - F. Piacentini
Da "il centro" n. 44 - gennaio/aprile 1994 - F. Piacentini
Dal cronico e dal libro della fabbriceria
Da "il centro" n. 60 - ottobre/dicembre 2000 - A. Spiriti/G. Paciarotti
Da "il centro" n. 76 - maggio/settembre 2006 - Laboratorio San Gregorio s.r.l.
Da "il centro" n. 75 - gennaio/aprile 2006 - M. Colombi, G. Chiaravalle
Da "il centro" n. 81 - giugno/settembre 2008 - F. Piacentini
Da "il centro" n. 44 - gennaio/aprile 1994 - F. Piacentini
Dal cronico e dal libro della fabbriceria
Da "il centro" n. 60 - ottobre/dicembre 2000 - A. Spiriti/G. Paciarotti
Da "il centro" n. 76 - maggio/settembre 2006 - Laboratorio San Gregorio s.r.l.
La prima pietra dell'attuale Parrocchiale viene posta il 20 aprile 1760 ad opera del Parroco Giuseppe Antonio Luvini, successore di Giacomo Oggioni. L'edificazione prosegue, quindi, con il Parroco Cristoforo Ramazzotti, subentrato al Luvini nel 1768.
Nel corso dei lavori di rifacimento della copertura effettuati nel 1999, un'iscrizione incisa nella viva calce sul muro presso il ferro che sostiene il baldacchino, quindi, alla sommità dell'abside, attesta in data 24 settembre 1763 l'avanzamento nella realizzazione della struttura. La copertura definitiva con la posa del tetto ha luogo nel 1765.
L'insorgere di gravi problemi finanziari rallenta il procedere dei lavori e, nel 1771, previa autorizzazione della Reale Giunta, vengono venduti all'asta i beni della chiesa del Luogo Pio Ferrario e del Legato Giovanni Macchio, essendo esaurita la disponibilità del Legato del Parroco Oggioni. Esattamente come affermato nell'iscrizione relativa a questa donazione.
Con il ricavo dell'incanto e le prestazioni del popolo si pagano i debiti e si riattivano i lavori. Come menziona il Libro Cronico "si incominciò di nuovo a cuocere i mattoni in due fornaci che si costruirono nel territorio verso l'Oratorio di San Protaso". Così si completò la costruzione del tempio con la sagrestia, il sagrato, l'intonacatura interna, gli stucchi, i serramenti e le invetriate ed infine un "paramento intero di seta bianca ricamato in oro".
L'iscrizione, datata 1777 fa, quindi, riferimento alla sostanziale realizzazione della complessiva struttura della Parrocchiale, nonché delle indispensabili rifiniture e dotazioni.
L'inizio ufficiale del culto con la benedizione della nuova chiesa da parte del Prevosto di Gallarate, qui giunto con speciale delegazione, avviene in data 27/06/1779.
"Così aveva principio la chiesa dedicata alla SS. Trinità sotto l'invocazione e il patrocinio di Maria del Rosario e di S. Leone"; la consacrazione definitiva della chiesa avverrà soltanto il 25 agosto 1932 ad opera del Beato Card. Ildefonso Schuster. Come riporta la targa in marmo di Carrara situata all'ingresso della chiesa parrocchiale sulla lesena sinistra successiva al Battistero.
L'evento è così ricordato dal "Cronico": "La cerimonia di consacrazione preceduta da una veglia santa ebbe inizio verso le tre di notte per protrarsi poi sino alle sei, quando S. E. celebrò Messa con la Comunione generale, cui seguì la Cresima".
Nel corso dei lavori di rifacimento della copertura effettuati nel 1999, un'iscrizione incisa nella viva calce sul muro presso il ferro che sostiene il baldacchino, quindi, alla sommità dell'abside, attesta in data 24 settembre 1763 l'avanzamento nella realizzazione della struttura. La copertura definitiva con la posa del tetto ha luogo nel 1765.
L'insorgere di gravi problemi finanziari rallenta il procedere dei lavori e, nel 1771, previa autorizzazione della Reale Giunta, vengono venduti all'asta i beni della chiesa del Luogo Pio Ferrario e del Legato Giovanni Macchio, essendo esaurita la disponibilità del Legato del Parroco Oggioni. Esattamente come affermato nell'iscrizione relativa a questa donazione.
Con il ricavo dell'incanto e le prestazioni del popolo si pagano i debiti e si riattivano i lavori. Come menziona il Libro Cronico "si incominciò di nuovo a cuocere i mattoni in due fornaci che si costruirono nel territorio verso l'Oratorio di San Protaso". Così si completò la costruzione del tempio con la sagrestia, il sagrato, l'intonacatura interna, gli stucchi, i serramenti e le invetriate ed infine un "paramento intero di seta bianca ricamato in oro".
L'iscrizione, datata 1777 fa, quindi, riferimento alla sostanziale realizzazione della complessiva struttura della Parrocchiale, nonché delle indispensabili rifiniture e dotazioni.
L'inizio ufficiale del culto con la benedizione della nuova chiesa da parte del Prevosto di Gallarate, qui giunto con speciale delegazione, avviene in data 27/06/1779.
"Così aveva principio la chiesa dedicata alla SS. Trinità sotto l'invocazione e il patrocinio di Maria del Rosario e di S. Leone"; la consacrazione definitiva della chiesa avverrà soltanto il 25 agosto 1932 ad opera del Beato Card. Ildefonso Schuster. Come riporta la targa in marmo di Carrara situata all'ingresso della chiesa parrocchiale sulla lesena sinistra successiva al Battistero.
L'evento è così ricordato dal "Cronico": "La cerimonia di consacrazione preceduta da una veglia santa ebbe inizio verso le tre di notte per protrarsi poi sino alle sei, quando S. E. celebrò Messa con la Comunione generale, cui seguì la Cresima".
In un’iscrizione inclusa in una finta pergamena di dimensioni 9x19,5 cm, modellata sul lato posteriore del basamento dell'Angelo di destra dell'altare maggiore, c’è riportato: “Giuseppe Buzzi all'età di 25 anni, progettò e costruì. Anno 1786”. Questa semplice e sobria iscrizione ricorda il notevole impegno artistico prodotto dai Buzzi, famiglia di marmisti e di artisti insigni.
A Giuseppe Buzzi dobbiamo la progettazione non solo di questi Angeli ma dell'intero altare maggiore eretto negli anni 1778/1786. Questo il commento del "Cronico Parrocchiale" circa l'opera del giovane artista: "... lavoro perfettissimo di tutta sicurezza d'arte. Il vecchio stile barocco è ben coordinato dalle linee di una eleganza e simmetria che appagano l'occhio". Il padre Marcantonio Buzzi, collaborò alla posa in opera dell'altare maggiore, nonché alla posa delle balaustre (1779) delimitanti il perimetro dell'altare maggiore, perimetro oggi riarticolato. Da parte sua il nipote Gabriele Buzzi curò le decorazioni in marmo dell'altare.
Nella chiesa parrocchiale troviamo quattro grandi cappelle laterali dedicate a San Leone, a San Giuseppe, alla Beata Vergine del Rosario e al Crocifisso, una più piccola dedicata a San Giovanni Bosco e un Fonte Battesimale.
A Giuseppe Buzzi dobbiamo la progettazione non solo di questi Angeli ma dell'intero altare maggiore eretto negli anni 1778/1786. Questo il commento del "Cronico Parrocchiale" circa l'opera del giovane artista: "... lavoro perfettissimo di tutta sicurezza d'arte. Il vecchio stile barocco è ben coordinato dalle linee di una eleganza e simmetria che appagano l'occhio". Il padre Marcantonio Buzzi, collaborò alla posa in opera dell'altare maggiore, nonché alla posa delle balaustre (1779) delimitanti il perimetro dell'altare maggiore, perimetro oggi riarticolato. Da parte sua il nipote Gabriele Buzzi curò le decorazioni in marmo dell'altare.
Nella chiesa parrocchiale troviamo quattro grandi cappelle laterali dedicate a San Leone, a San Giuseppe, alla Beata Vergine del Rosario e al Crocifisso, una più piccola dedicata a San Giovanni Bosco e un Fonte Battesimale.
Cappella di "San Leone"
|
Le spoglie di San Leone (ritrovate nelle catacombe di san Callisto a Roma) nel 1779 vengono traslate dalla chiesa di San Rocco dai “Confratelli della buona morte” e collocate nella nicchia.
L'altare è in marmo con paliotto del XIX secolo in lastra di rame sbalzato e cesellato con medaglione centrale che effigia san Leone Martire. Sopra la nicchia c'è la pala rappresentante il “Sacro Cuore” opera di Pierino Rossini collocato nel maggio 1938. Nel dipinto si distinguono al centro la chiesa di Samarate, a sinistra il parroco, lo stesso pittore ed alcuni suoi congiunti. Sotto la pala la scritta “COR IESU SACRATISSIMUM MISERERE NOBIS” (Cuore Sacratissimo di Gesù abbi pietà di noi). La tela è racchiusa tra due colonne di marmo sovrapposte da un frontone. Sul lato destro l'affresco che rappresenta “San Leone Martire in prigione tentato dalle cortigiane” di autore ignoto datato fine XVIII secolo. Sopra l’affresco la scritta “HIS SUNT OPES ECCLESIAE” (Queste sono le ricchezze della Chiesa). Sul lato sinistro l'affresco che rappresenta “San Leone Martire davanti all’imperatore” di autore ignoto datato fine XVIII secolo. Sopra l’affresco la scritta “MERUIT ESSE HOSTIA CHRISTI”(Meritò di essere la vittima del Signore). Sopra la volta la scritta “LEO MARTIR CHRISTI”. Balaustra di chiusura in marmo opera di Gabriele Buzzi, anno 1793. |
|
Cappella di "San Giuseppe"
|
|
Nel 1790 la cappella è dipinta dal pittore Beretta di Legnano ed è dedicata a San Giuseppe.
L'altare è una donazione della famiglia Silva di Milano proveniente dalla chiesa di “San Carlo e Teresa” abbattuta nel 1804. Della stessa donazione fanno parte la statua di san Giuseppe in marmo di Carrara posta nella nicchia ed il paliotto ad alto rilievo collocato sotto l’altare rappresentante “La Natività” opera di ignoto datato XVIII secolo (il paliotto è stato restaurato nel 2010 dandogli l’antico splendore). Sopra la nicchia è la scritta “ITE AD JOSEPH” e medaglione con angeli opera del pittore Pierino Rossini eseguiti nel 1936. Sul lato destro un dipinto ad olio su tela raffigurante “San Giuseppe svegliato dall'angelo” di autore ignoto del XVII secolo e l'originale del quadro “Madonna della seggiola” dono della famiglia Garbini, messo su tela da Giovanni Malinverni nel 1930. Sul lato sinistro la tela “Riposo durante la fuga in Egitto” opera di Biagio Bellotti del XVIII secolo (restaurata nel 2000). Il soffitto è affrescato con angeli opera di Pierino Rossini nel 1936. All'esterno della volta la scritta “JOSEPH PATER, DEI NUTRITIUS” (Giuseppe, Padre a cui fu affidata la cura del Signore). |
Riposo durante la fuga in Egitto
|
Cappella di "San Giovanni Bosco"
|
|
Questa cappella è rimasta inutilizzata sino al 1933 poiché la destinazione era quella per l’accesso al campanile. Nel 1934 per festeggiare la canonizzazione di don Bosco si decide di abbellire la piccola cappella con una tela raffigurante il Santo circondato da fanciulli, opera del pittore Federico Gariboldi di Varese.
Sul lato destro il dipinto ovale raffigurante San Domenico Savio con sotto il motto “la morte ma non peccati”. Sul lato sinistro il dipinto ovale raffigurante Santa Maria Mazzarello con sotto il motto “fa le tue opere come se fosse l’ultima di tua vita”. I due ovali sono opera del pittore Pierino Rossini eseguiti negli anni 1950/55. Sul soffitto della volta sono affrescati due angeli con serti di rose ed un cartiglio “DA MIHI ANIMAS CAETERA TOLLE” (Concedimi le anime, toglimi il resto) opera di Pierino Rossini, anni 1935/36. |
Cappella della "Beata Vergine del Rosario"
|
Nel 1779, la statua della Vergine, proveniente dalla chiesa di San Salvatore e portata dai Confratelli del SS. Sacramento, viene collocata nella nicchia.
L'altare è realizzato in marmo da Gabriele Buzzi nel 1793. Il paliotto di rame sbalzato e cesellato con al centro il monogramma della Vergine è del XIX secolo. La Nicchia è affiancata da due colonne in marmo con frontone spezzato ai cui lati siedono le statue della “Fede” e della “Carità”. Nella parte centrale la “Colomba dello Spirito Santo”. La statua della “Vergine con Gesù bambino” è una scultura lignea dorata e dipinta di autore ignoto della prima metà del XVII secolo. Sul lato destro un dipinto ad olio su tela “L’incoronazione della Vergine con Gesù Cristo, l’Eterno Padre e lo Spirito Santo” di autore ignoto del XVII secolo. Sul lato sinistro la tela che rappresenta la “Vergine con sant’Anna e Gesù bambino” di autore ignoto del XVII secolo. Sul soffitto un medaglione affrescato con angeli che sorreggono una corona opera di Pierino Rossini eseguito nel 1936. La scritta “REGINA SACRATISSIMI ROSARII” (Regina del SS. Rosario) è all’esterno della volta. |
|
Cappella del "Crocifisso"
|
|
Nel 1790 la cappella è dipinta dal pittore Beretta di Legnano ed è dedicata a Sant'Agata.
Nel 1830 la cappella è riordinata e, perse le pitture originarie, viene eretto l’altare. Nella nicchia sovrastante viene collocato per devozione popolare il Crocifisso eseguito da un intagliatore di Intra nel 1735 proveniente dalla chiesa di San Rocco. Sopra la croce particolare è il cartello con scritte in ebraico, greco e latino. L'altare è realizzato in marmo bianco con caratteristiche neoclassiche. Le colonne hanno capitelli corinzi. A lato è posta la statua della Madonna Addolorata di autore ignoto del XVII secolo (restaurata nel 2006). Sul lato destro la pala “Apparizione della Madonna con bambino e San Pietro a Sant'Agata in carcere” l'autore è Melchiorre Gherardini detto il Ceranino (XVII secolo) (restaurata nel 1998/1999) Sul lato sinistro la pala “La Resurrezione di Cristo” (XVII secolo) attribuito a Camillo Procaccini (restaurata nel 2006). Sul soffitto “Angeli che sorreggono la Sindone” opera di Pierino Rossini (anno 1936). All'esterno della volta un cartiglio con la scritta “O CRUX AVE SPES UNICA” (salve o Croce unica speranza). La balaustra di chiusura realizzata nel 1793 è opera di Gabriele Buzzi di Viggiù. |
Madonna AddolorataLa statua in legno policroma dell’Addolorata era posizionata prima in oratorio e poi in Sacrestia, ora dopo il restauro, da parte del Laboratorio San Gregorio di Busto Arsizio, diretto e seguito dall’ispettrice della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Milano Isabella Marchi, è posta ai piedi del SS. Crocefisso. Per quanto è riguardato l’intervento lo stato di conservazione al quale è giunta a noi era apparso nel complesso buono. L’opera, di buona fattura, databile XVII/XVIII secolo, è stata ricavata da un unico blocco di legno massiccio, che nonostante lo svuotamento parziale della polpa lignea dal basamento, possiede comunque un gravoso peso.
Il supporto ligneo della statua e lo strato preparatorio non presentavano gravi problemi di perdita di coesione, né grosse fessurazioni e attacchi xilofagi. Sono apparsi tuttavia sollevamenti e mancanze di pellicola pittorica, dovute per la maggior parte a colpi ricevuti durante i vari spostamenti per cambi di collocazione della statua che, in corso di restauro, sono stati consolidati mediante iniezioni di resine acriliche e opportunamente fatti riaderire al supporto ligneo. L’opera inoltre, risultava coperta da uno spesso deposito di sporco grasso e polveri, aggravata dall'ossidazione della vernice protettiva ingiallita, che ne alterava la cromia originale. Le operazioni di pulitura durante il restauro, mediante azione diversificata a seconda del tipo di problematiche presenti sulla superficie dipinta, hanno consentito di recuperare i reali valori cromatici e di liberare la materia originale dalle sovrammissioni, se pur limitati al manto blu della Vergine. Gli interventi si sono susseguiti con le azioni si stuccatura delle mancanze di preparazione e con la reintegrazione pittorica delle lacune; infine il restauro della statua dell’Addolorata è stato concluso nebulizzando una vernice trasparente a scopo protettivo sull'intera opera. Laboratorio San Gregorio s.r.l. Restauro Opere D’Arte |
Apparizione della Madonna col Bambino e San Pietro a sant'Agata in carcere.
|
Resurrezione di Cristo
|
Fonte Battesimale
|
|
Il fonte battesimale è opera di Girolamo Buzzi. Proviene dalla chiesa di San Salvatore dove era stato posizionato nel 1747. E’ stato trasferito nella sede attuale il 14 dicembre 1794.
Il Fonte battesimale è composto da un basamento a stele sopra il quale si apre il curvo bacino ottagonale. Il catino in rame e stato realizzato nel 1788 dal ramaro Matteo Rossi; è ricoperto da una calotta di rame sbalzato con la rappresentazione del “Battesimo di Gesù nel fiume Giordano” opera eseguita negli anni 1970/80. Ai lati del tempietto due tabernacoli in legno; quello di destra reca le lettere “O.S.” (Oli Santi) Sul soffitto dipinto raffigurante “San Giovanni Battista che battezza Gesù Cristo” eseguito nel 1913/14 dal pittore Mario Chiodo Grandi. Il tempietto è delimitato da un cancelletto in ferro battuto realizzato nel 1792 da Ignazio Borghi. |
L'organo "Costamagna"
Fra le prime decisioni assunte dal parroco don Riccardo Lavazza, nel secondo dopoguerra, vi fu la realizzazione di un organo commissionato alla ditta “Costamagna” di Milano (1956). Lo strumento, che non conobbe nei decenni successivi una manutenzione sistematica, dopo circa mezzo secolo di onorato servizio si presentava in uno stato così degradato da risultare inadeguato all'esecuzione di brani. Questa situazione ha fatto propendere per un intervento radicale che riportasse lo strumento all'originario splendore.
I lavori cominciarono nel marzo 2005 interessando prima il “corpo centrale“ dell'organo (composto da 400 canne), posto in coro, quindi i due laterali, “l'espressivo” a destra (composto da 920 canne) e il “grand'organo” a sinistra (composto da 650 canne), non senza usare l'accortezza di mantenere in funzione una delle parti per ottemperare alle esigenze liturgiche.
Tra i primi interventi la rimozione della consolle, che ora accoglie una moderna strumentazione elettronica entro il guscio di legno antico.
Si sono rimosse tutte le canne sia in legno sia in stagno. Tutte le canne sono state catalogate, marcate dove necessario. Tutti i cassetti di ogni somiere sono stati aperti, puliti, verniciati con vernici antiparassite. Sono state controllate, pulite e rimesse in sede tutte le valvole (ventilabri). Tutti i mantici di comando dei relativi ventilabri sono stati sostituiti. Alle canne di legno è stato fatto un trattamento antiparassita e sono state pulite anche all’interno.
Si è provveduto al rimontaggio generale, al ricablaggio totale, e alla messa in posa di tutte le canne.
I motori dei ventilatori sono stati smontati, puliti e controllati, ed infine sono stati rimontati e rinchiusi in apposite scatole di legno per diminuire il più possibile il rumore di fondo generato.
Sostanzialmente i lavori sopraccitati sono stati ripetuti per gli altri due corpi dell’organo, il sinistro e il destro.
La canna più grande è di legno, misura circa 5 metri di altezza e ha una sezione quadrata di circa 60x60 cm. La canna più piccola è di stagno e misura circa 5 cm di altezza.
E’ stata sostituita poi la trasmissione elettrica filare fra consolle e organi con un sistema simile a fibra ottica, molto più affidabile e pratico: basti osservare che in precedenza fra consolle e organo era posto un fascio di circa 200 fili, mentre ora è posto solo un filo del diametro di 6 mm.
I lavori terminarono nel 2006 dopo aver rifatto l’accordatura generale, e il 21 settembre, durante la “Sagra del Crocifisso”, ci fu l’inaugurazione dell’organo restaurato con un concerto del maestro Sergio Paolini di Busto Arsizio.
I lavori cominciarono nel marzo 2005 interessando prima il “corpo centrale“ dell'organo (composto da 400 canne), posto in coro, quindi i due laterali, “l'espressivo” a destra (composto da 920 canne) e il “grand'organo” a sinistra (composto da 650 canne), non senza usare l'accortezza di mantenere in funzione una delle parti per ottemperare alle esigenze liturgiche.
Tra i primi interventi la rimozione della consolle, che ora accoglie una moderna strumentazione elettronica entro il guscio di legno antico.
Si sono rimosse tutte le canne sia in legno sia in stagno. Tutte le canne sono state catalogate, marcate dove necessario. Tutti i cassetti di ogni somiere sono stati aperti, puliti, verniciati con vernici antiparassite. Sono state controllate, pulite e rimesse in sede tutte le valvole (ventilabri). Tutti i mantici di comando dei relativi ventilabri sono stati sostituiti. Alle canne di legno è stato fatto un trattamento antiparassita e sono state pulite anche all’interno.
Si è provveduto al rimontaggio generale, al ricablaggio totale, e alla messa in posa di tutte le canne.
I motori dei ventilatori sono stati smontati, puliti e controllati, ed infine sono stati rimontati e rinchiusi in apposite scatole di legno per diminuire il più possibile il rumore di fondo generato.
Sostanzialmente i lavori sopraccitati sono stati ripetuti per gli altri due corpi dell’organo, il sinistro e il destro.
La canna più grande è di legno, misura circa 5 metri di altezza e ha una sezione quadrata di circa 60x60 cm. La canna più piccola è di stagno e misura circa 5 cm di altezza.
E’ stata sostituita poi la trasmissione elettrica filare fra consolle e organi con un sistema simile a fibra ottica, molto più affidabile e pratico: basti osservare che in precedenza fra consolle e organo era posto un fascio di circa 200 fili, mentre ora è posto solo un filo del diametro di 6 mm.
I lavori terminarono nel 2006 dopo aver rifatto l’accordatura generale, e il 21 settembre, durante la “Sagra del Crocifisso”, ci fu l’inaugurazione dell’organo restaurato con un concerto del maestro Sergio Paolini di Busto Arsizio.
Il campanile e le campane
Nel 1880, la chiesa della SS. Trinità, ch’era sorta da oltre un secolo, era ancora priva della torre campanaria.
Giulio da Samarate, allora, scriveva che “il disastro d’essere senza campanile e privi di un orologio ci rende… una discordia tra di noi e una mormorazione dei paesi vicini. (A)Quistiamo una nomina di indegni persone e pieni di crudeltà. Priviamo il commercio dei poveri operai e perdiamo il buon senso religioso”.
Ma,dopo infinite beghe e suppliche alle autorità d’allora, nel 1883, benedetta dal Parroco Luigi Lodini, venne posta la prima pietra dell’opera.
“La cava del fondamento consiste meter 7,50 tanto larghezza e longhezza, cioè quadratura e di fondezza circa 4 metri e cinquanta centimetri e si può dire quasi tutto lavoro lo fanno gratuito”.
La costruzione durò circa tre anni.
“Di una solidità meravigliosa e di altezza e larghezza comodissima. Nel corso dei lavori si volle correggere il disegno e ne vennero alcuni difetti nell’ampiezza delle linee e del capitello. La torre, sino alla croce di sommità, misura metri 46 dal suolo. Costò, dalle fondamenta, in danaro, lire 27 mila”. (Mons. Virginio Civati – 1 luglio 1887)
Il Comune intervenne anche per la posa di un orologio e diede dapprima un contributo di lire 3.500 e poi un altro di lire 5.000.
Le prime campane furono installate nel 1887: cinque provenivano dal Santuario della Madonna Addolorata in Rho e tre dalla vecchia chiesa del SS. Salvatore. Ma non facevano concerto e, nel 1933, vennero sostituite con le attuali.
Uno spaventoso ciclone, la sera del 23 luglio 1910 piegò la croce, del peso di oltre 500 kg, che è collocata sulla sommità della torre e che poi venne ripristinata.
Nel 1933 il parroco don Antonio Spreafico celebrava il 25° di parrocchia e un comitato aveva deciso di ricordare l'evento con un nuovo Concerto Campanario.
Il 5 maggio 1933 le vecchie campane vengono calate dalla torre e mandate a rifondere alle Fonderie Fratelli Barigozzi di Milano per avere un concerto univoco (Si bemolle grave).
Il nuovo complesso di 8 campane, del peso complessivo di 82,45 quintali, 21 in più del precedente (il solo campanone pesa 2461 kg), il 17 luglio sfilò in processione, su sei carri, per le vie del paese.
Il 22 luglio, alla presenza del Prevosto di Gallarate, di tutto il clero della Pieve, delle autorità civili e di una folla innumerevole, il Cardinale Ildefonso Schuster, Arcivescovo di Milano, procedette alla consacrazione delle nuove campane.
Finalmente, il 31 luglio, "...fra la meraviglia ed il giubilo del popolo ebbe inizio il sollevamento delle campane a mezzo di potenti carrucole e grosse funi tirate di forza dagli uomini e da giovani. E così pure il 1° e il 2 agosto, sempre alla presenza del popolo che, per partecipare allo straordinario spettacolo, dimenticò i lavori dei campi. Quando il campanone giunse alla sommità una esplosione di evviva e di battimani inneggiò il suo ingresso nella torre.
Il sabato seguente, 5 agosto 1933, dedicato alla Beata Vergine Maria della Neve, a mezzodì, salutando la Vergine Santissima con il suono del suo Angelus Domini le otto campane, in tono solenne, per la prima volta, squillarono il loro concerto".
Tutta l'operazione di integrazione del bronzo, di fusione, posa, installazione, costò 45.699 lire.
70 anni dopo, il 9 luglio 2003, le campane vengono calate dalla torre per essere mandate al restauro. Il 14 settembre, alla “Sagra del Crocifisso”, vengono benedette da Mons. Francesco Ceriotti assieme al parroco don Cesare Gerosa e il 22 settembre vengono ricollocate sul campanile. Venerdì 10 ottobre il suono festoso e solenne a distesa ha segnalato il completamento del restauro del concerto delle campane del nostro campanile.
Giulio da Samarate, allora, scriveva che “il disastro d’essere senza campanile e privi di un orologio ci rende… una discordia tra di noi e una mormorazione dei paesi vicini. (A)Quistiamo una nomina di indegni persone e pieni di crudeltà. Priviamo il commercio dei poveri operai e perdiamo il buon senso religioso”.
Ma,dopo infinite beghe e suppliche alle autorità d’allora, nel 1883, benedetta dal Parroco Luigi Lodini, venne posta la prima pietra dell’opera.
“La cava del fondamento consiste meter 7,50 tanto larghezza e longhezza, cioè quadratura e di fondezza circa 4 metri e cinquanta centimetri e si può dire quasi tutto lavoro lo fanno gratuito”.
La costruzione durò circa tre anni.
“Di una solidità meravigliosa e di altezza e larghezza comodissima. Nel corso dei lavori si volle correggere il disegno e ne vennero alcuni difetti nell’ampiezza delle linee e del capitello. La torre, sino alla croce di sommità, misura metri 46 dal suolo. Costò, dalle fondamenta, in danaro, lire 27 mila”. (Mons. Virginio Civati – 1 luglio 1887)
Il Comune intervenne anche per la posa di un orologio e diede dapprima un contributo di lire 3.500 e poi un altro di lire 5.000.
Le prime campane furono installate nel 1887: cinque provenivano dal Santuario della Madonna Addolorata in Rho e tre dalla vecchia chiesa del SS. Salvatore. Ma non facevano concerto e, nel 1933, vennero sostituite con le attuali.
Uno spaventoso ciclone, la sera del 23 luglio 1910 piegò la croce, del peso di oltre 500 kg, che è collocata sulla sommità della torre e che poi venne ripristinata.
Nel 1933 il parroco don Antonio Spreafico celebrava il 25° di parrocchia e un comitato aveva deciso di ricordare l'evento con un nuovo Concerto Campanario.
Il 5 maggio 1933 le vecchie campane vengono calate dalla torre e mandate a rifondere alle Fonderie Fratelli Barigozzi di Milano per avere un concerto univoco (Si bemolle grave).
Il nuovo complesso di 8 campane, del peso complessivo di 82,45 quintali, 21 in più del precedente (il solo campanone pesa 2461 kg), il 17 luglio sfilò in processione, su sei carri, per le vie del paese.
Il 22 luglio, alla presenza del Prevosto di Gallarate, di tutto il clero della Pieve, delle autorità civili e di una folla innumerevole, il Cardinale Ildefonso Schuster, Arcivescovo di Milano, procedette alla consacrazione delle nuove campane.
Finalmente, il 31 luglio, "...fra la meraviglia ed il giubilo del popolo ebbe inizio il sollevamento delle campane a mezzo di potenti carrucole e grosse funi tirate di forza dagli uomini e da giovani. E così pure il 1° e il 2 agosto, sempre alla presenza del popolo che, per partecipare allo straordinario spettacolo, dimenticò i lavori dei campi. Quando il campanone giunse alla sommità una esplosione di evviva e di battimani inneggiò il suo ingresso nella torre.
Il sabato seguente, 5 agosto 1933, dedicato alla Beata Vergine Maria della Neve, a mezzodì, salutando la Vergine Santissima con il suono del suo Angelus Domini le otto campane, in tono solenne, per la prima volta, squillarono il loro concerto".
Tutta l'operazione di integrazione del bronzo, di fusione, posa, installazione, costò 45.699 lire.
70 anni dopo, il 9 luglio 2003, le campane vengono calate dalla torre per essere mandate al restauro. Il 14 settembre, alla “Sagra del Crocifisso”, vengono benedette da Mons. Francesco Ceriotti assieme al parroco don Cesare Gerosa e il 22 settembre vengono ricollocate sul campanile. Venerdì 10 ottobre il suono festoso e solenne a distesa ha segnalato il completamento del restauro del concerto delle campane del nostro campanile.
|
|
Campane di Samarate
Concerto di 8 campane in Sib2 calante |